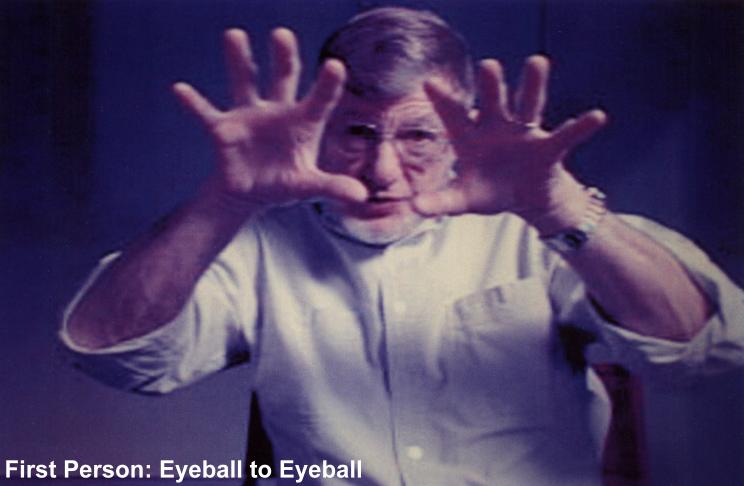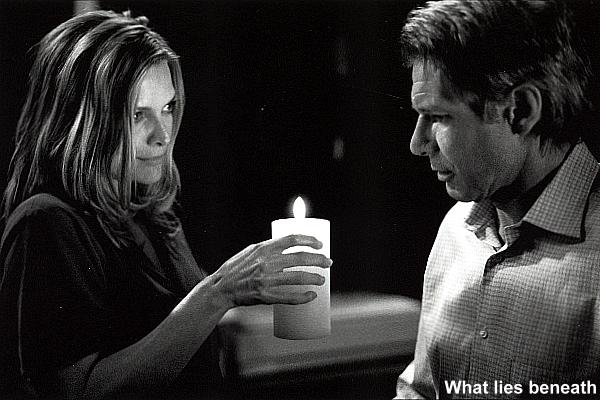57ma MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA
 |
A cura di Marco Monsurrò e Tommaso Bartalesi
Questa edizione del festival sarà ricordata soprattutto come quella della consacrazione di Clint Eastwood, leone d'oro alla carriera ed unico protagonista di un ricchissimo tributo, che ha raccolto i momenti più importanti della sua carriera: dagli esordi italiani con Leone ai grandi successi internazionali come regista. Una scelta che era nell'aria da tempo (Saada e Toubiana dei Cahiers gli hanno appena dedicato una monografia) e che rende giustizia alla coerenza di un autore che, ha sempre fatto dell'asciuttezza e della linearità narrativa del cinema classico, una regola guida del suo cinema (ma il disincanto che emerge dai suoi film, è tipico della sua generazione), anche a rischio di essere tacciato di conservatorismo o di neo-classicismo dai suoi detrattori. Ma questo è stato anche il festival della riscossa del cinema italiano, presente nella sezione competitiva con ben quattro film (I cento passi, Denti, Il partigiano Johnny, La lingua del santo), tutti di buon livello qualitativo e ben accolti dal pubblico; una risposta secca all'indifferenza con cui Cannes ha snobbato le proposte italiane (nessun film in concorso) nella scorsa edizione. Una sezione, quella del concorso, dominata da nomi di grande prestigio, che non sempre hanno soddisfatto le aspettative della platea lagunare. Pensiamo soprattutto a Doctor T and the women di Robert Altman, sicuramente il suo peggior film del decennio, che tenta senza successo la carta della commedia satirica (nel mirino la ricca borghesia di Dallas, cui Richard Gere dà corpo e voce) al femminile o a The man who cried di Sally Potter, insipido e fastoso mélo, che sarà ricordato solo per l'eccellente fotografia di Sacha Vierny, abituale collaboratore di Greenaway e Resnais. Ma anche film svogliati come Liam, di Stephen Frears, che vira improvvisamente una gradevole commedia sull'infanzia in un cupo dramma politico (un disoccuppato, simpatizzante fascista, sfigura involontariamente la figlia durante l'attacco alla villa di un ricco ebreo, dove lei, a sua insaputa, lavorava) o Selon Matthieu di Xavier Beauvois, confuso dramma sentimentale in cui un giovane operaio si innamora della seducente moglie del padrone, con ovvi risvolti sociali. Forse il limite più grande dei selezionatori è stato adagiarsi eccessivamente su autori già molto noti al grande pubblico, piuttosto che puntare su qualche esordiente (l'unica opera prima era l'esecrabile O fantasma di Rodrigues). La giuria presieduta da Milos Forman ha finito così col premiare un buon film a tesi come Il Cerchio di Jafar Panahi (Il palloncino bianco, Lo specchio), lodevole per l'impegno sociale e politico (la denuncia della subalternità femminile in Iran), ma di certo non entusiasmante sul piano del linguaggio e della ricerca stilistica. Ecco allora che, come al solito, le proposte migliori sono venute dalle sezioni collaterali (Cinema del presente e Nuovi Territori); una su tutte: Estate romana di Matteo Garrone, già autore dell'apprezzato Ospiti, che attraverso le tragicomiche avventure di tre artistoidi disadattati e problematici evoca un senso di disagio e di inadeguatezza esistenziale insoliti al nostro cinema (spesso molto più consolatorio e "carino", che scomodo ed interrogativo). Un film negativo e senza risposte, ma certo non un rifiuto e una negazione della visione (cinematografica e tout court) come quello opposto da Monteiro con Branca de neve, oltre due ore di schermo nero, intervallate da brevissimi lampi visivi (un cielo limpido, un accenno di panoramica, subito abortito, su un sito archeologico), mentre voci recitano versi della Biancaneve di Robert Walser; un epitaffio inappellabile del racconto per immagini, una sorta di funerale estremo e provocatorio della settima arte (ma se si vince la sorpresa iniziale, giurano gli irriducibili che hanno resistito fino alla fine, il risultato può essere molto seducente). Da segnalare anche la serie documentaria First Person di Errol Morris, di cui sono stati presentati alcuni episodi in video prodotti per la televisione americana. Si tratta di interviste a personaggi apparentemente ordinari, che raccontano storie autobiografiche al limite dell'inverosimile. La commistione di immagini di repertorio, disegni, didascalie ed una colonna sonora che esalta il lato noir e di mistero del racconto fa precipitare lo spettatore in un microcosmo avvincente e fagocitante; la fiction si fonde con il documentario con grande originalità e l'ipocrisia del reality-show (che oggi è assunta come modello totalizzante dai programmatori di palinsesti) è smascherata e messa a nudo attraverso la rappresentazione del suo stesso sensazionalismo. Ecco allora che un pappagallo, unico testimone di un omicidio, può diventare il test chiave di un processo penale (The Parrot); uno scrittore in cerca di successo può approfittare della fitta corrispondenza epistolare con lo psicotico killer Unabomber (In The Kingdom Of The Unabomber) per farsi pubblicità; oppure può capitare di appassionarsi alle vicende di Clyde Roper, insigne zoologo dello Smithsonian Institute (Eyeball to Eyeball), che ha speso tutta la vita nel tentativo di catturare una mitologica e mostruosa creatura marina: il calamaro gigante. (M.M.)
Brother di Takeshi Kitano (Fuori Concorso)
"Il Giappone si è completamente scordato cosa sia una vera guerra. L'America ne fa sempre qualcuna, tanto per non perdere l'abitudine (.) " (da: T. Kitano, Ecco perché mi odiano).
'Beat' Takeshi va alla guerra. E questo, di per se, non è una gran novità. Solo che questa volta il programma è ambizioso: la conquista dell'America. Portare il confronto con una delle basi del suo cinema, il gangster-movie americano, direttamente a casa sua: per saldare probabilmente il conto una volta per tutte. E per farlo si blinda in una solida armatura, narrativa e produttiva. Si tratta infatti di una co-produzione USA/Gran Bretagna/Giappone, sotto l'egida dell'inglese Jeremy Thomas (produttore, tra gli altri, di Bertolucci e Oshima, nel cui film dell'83, Merry Christmas Mr. Lawrence, recitava Kitano). I fidati collaboratori del "Kitano Gumi" (la Kitano-troupe) vengono integrati con le maestranze USA: "Ho sentito dire per anni che le troupe americane non lavorano sodo e che cazzeggiano tutto il giorno, mangiando sul set. (.) Una volta iniziato a girare, gli americani lavoravano anche più dei giapponesi. Mi hanno davvero impressionato." Uno a zero, palla al centro.
Dal punto di vista narrativo, Brother è un classico "rise and fall" hollywoodiano: lo yakuza Yamamoto (Kitano) è costretto a fuggire dal Giappone e si rifugia a Los Angeles, dove vive il fratello, piccolo spacciatore di poca fortuna. In breve tempo, Yamamoto mette in piedi una gang che scala i gradini del potere, eliminando agguerriti concorrenti. Arriva la ricchezza, ma la posta in gioco si fa più alta: il punto di non ritorno arriva quando si giunge allo scontro frontale con la mafia italiana. E' un bagno di sangue, ma mentre la fine si avvicina c'è il tempo per scoprire che l'unico ad aver colto il vero spirito della fratellanza yakuza è Denny (il bravo Omar Epps), un nero con cui Yamamoto aveva avuto un violento scontro al suo arrivo nel quartiere. La maschera di sfinge di Kitano sfida la violenza del mondo con beffardo distacco e il senso di fatalità del destino incombente sospende il tempo: ai personaggi, in attesa che la loro parabola si compia, restano l'ironia e l'amicizia, più salda di un vincolo di sangue.
Dopo la deriva ludica di Kikujiro, si torna quindi dalle parti di Sonatine e Boiling Point. Gli elementi caratterizzanti del cinema di Kitano passano indenni la traversata del Pacifico, pur inquadrati in binari più rigorosi: ma la fedeltà a se stesso non impedisce, a chi lo segue da anni, la sensazione di déjà-vu. Sembra proprio che per il suo primo film all'estero il nostro abbia preferito un ritorno al passato e riapra un capitolo che con Hana- bi sembrava definitivamente chiuso. (T.B.)
Small time crooks
di Woody Allen (Fuori Concorso)Small time crooks è per Allen un ritorno alle origini, alle commedie scoppiettanti, squilibrate ed alienate dei primi anni settanta. Questa volta Woody gioca a fare l'arricchito e interpreta la parte di un mediocre (gli amici lo chiamano ironicamente "the brain", la mente, ma lui è convinto di meritare l'epitome), esponente della low class, che si ritrova improvvisamente e immeritatamente ricco imprenditore dolciario, con tanto di attico, domestici e velleità cultural-mondane della ambiziosa moglie (un'eccellente Tracey Ullman). Insomma Manhattan vista dal basso, dalla parte di chi, la ricchezza l'ha immaginata solo al cinema e la cultura l'ha conosciuta (o meglio, è convinto di averla incontrata) ai talk-show televisivi. Purtroppo il gioco riesce solo a metà: se, infatti, è spassoso vedere Allen entrare in scena vestito in bermuda e t-shirt di quart'ordine e replicare le gag slapstick degli esordi (il colpo ai danni della banca è una magistrale lezione di comicità fisica), l'impressione iniziale finisce con lo spegnersi nei prevedibili sviluppi della seconda parte (la gag della collana gira a vuoto), in cui scompaiono del tutto gli spassosi comprimari, che avevano tenuto felicemente banco fino all'irresistibile ascesa della coppia. Ma forse quello che manca di più è qualche squarcio di paradossale follia a cui il primo, irriverente Allen ci aveva abituati. È anche vero che Small time crooks è, nell'insieme, un gradevole diversivo rispetto alla sua produzione abituale; ma sospettiamo che, nel suo caso, la prolificità (gira in media un film l'anno) non sia sempre un bene. (M.M.)
Sud Side Stori (la vera storia di Romea e Giulietto) di Roberta Torre (Sogni e visioni)
"Trentamila £ire come fosse un girotondo, trentamila £ire a Sud del mondo".
Che dire? Si sa che l'Italia esprime due diverse economie e questa ne è un'ulteriore conferma: chi desideri un po'di compagnia a pagamento trova, a Palermo, prezzi ben più abbordabili di quelli praticati al Nord.
Roberta Torre, invece, ha un'idea sola, ben delineata, su cui ha costruito svariati corti (alcuni molto buoni) e due lungometraggi. E adesso comincia a mostrare la corda. Il film, come si intuisce dal titolo (e dal terrificante sottotitolo), è la storia (stori?) di un amore osteggiato: la prostituta nigeriana Romea (Forstine Ehobor, alla sua prima esperienza) e il cantantucolo palermitano Giulietto (in realtà il livornesissimo solista degli Ottavo Padiglione Bobo Rondelli). Scontro tra due razze, due culture, due Sud di qualcosa, due tipi di pregiudizio diversi, ma uguali. Il tutto in musical: un frullato di kitsch e camp, salti mortali di scenografia e sartoria teatrale, canzoncine, Mario Merola contro Little Toni, magia bianca contro magia nera, prostitute (forse) vere contro popolane veraci. Manca però l'effetto sorpresa: tutto quello che in Tano da morire aveva colpito per originalità e freschezza (facendo gridare molti al miracolo), una volta diventato prevedibile e previsto, resta poco più che una marca stilistica. La trash-fiction antropologica della Torre, pur con la sua scoppiettante vivacità, risulta alla fine piuttosto sterile. E soprattutto non regge la dimensione del lungometraggio. Sul film incombe poi la Spada di Damocle distributiva dell'Istituto Luce, un autentico becchino per il cinema italiano. Aspettiamo tempi migliori. (T.B.)
What lies beneath di Robert Zemeckis (Sogni e visioni)
Le premesse sono subito chiare. Zemeckis ha deciso di girare un film hitchcockiano o meglio ancora, alla maniera del vecchio maestro del brivido. Ecco allora che frulla insieme Rebecca e Il sospetto, La finestra sul cortile e La donna che visse due volte (ma anche Shining e più in generale certe reiterazioni kubrickiane) e sceglie come protagonista un'icona delle bionde algide (in apparenza) e sofisticate che tanto piacevano al vecchio Hitch: Michelle Pfeiffer. Il risultato è, soprattutto nella prima parte, sorprendente. La falsa pista voyeuristica (Pfeiffer osserva il vicino di casa, che sospetta essere un uxoricida) distrae il pubblico dalla traccia paranormale, e consente a Zemeckis di dilatare al massimo l'attesa e di moltiplicare i colpi di scena. Purtroppo, nonostante un integrazione magistrale degli effetti visivi digitali (realizzati da ILM) e l'ottima prova della Pfeiffer, la seconda parte scivola nella prevedibilità dello scontro fisico (il villain è Harrison Ford) e Zemeckis, troppo preso dalla voglia di intensificare le emozioni, tradisce il pragmatismo drammaturgico di Hitchcock, affidandosi a un finale che il maestro del brivido avrebbe definito quantomeno inverosimile. (M.M.)
Denti
di Gabriele Salvatores (Concorso)Denti è un film umorale (nel senso di intriso di umori, dolori, possesso, sangue) ed allucinato, tormentato ed "indifeso" secondo la definizione dello stesso Salvatores. Un film che è ancora fuga dalla realtà (ma anche dalla prospettiva generazionale, unica vera ossessione del regista) e viaggio, ma stavolta nel senso più ampio possibile. Il personaggio di Antonio (un Rubini insostituibile) passa da un dentista all'altro, barcamenandosi tra presente e passato, dalla fisicità di un assenza (i denti, con la loro muta materialità) all'immaterialità di una presenza (il fantasma della madre, con la quale ha un rapporto irrisolto di morbosa complicità). Va visto però con una precauzione: abbandonarsi al flusso di immagini senza troppo razionalizzare, reagendo con lo stomaco, con i nervi, non opponendo resistenza con la testa. Perché Denti è pura, mirabolante superficie. (M.M.)
La lingua del santo
di Carlo Mazzacurati (Concorso)Antonio e Willy sono due quarantenni emarginati e senza prospettive, due reietti, che si trovano all'improvviso nella condizione di riscattare i loro fallimenti e mostrare quanto valgono. La lingua del santo ha il sapore di certe vecchie commedie all'italiana, soprattutto per la felice scelta degli interpreti e la capacità di costruire personaggi credibili (anche se il macchiettismo, pensiamo soprattutto a Marescotti, è sempre in agguato), convincenti. Bentivoglio (l'attore più versatile del nostro cinema), con la sua maschera di dolore ed irrisoluta indecisione, Albanese con la sua fisicità prorompente e la sferzante energia riescono in un'alchimia, che almeno sulla carta, non era affatto scontata. Il film ha anche il pregio di una forte coerenza figurativa, la storia si dipana tra Padova, i Colli Euganei e la laguna veneziana, e gioca le sue carte migliori nel definire una dimensione provinciale, straniante (il ricco e produttivo nord-est visto con gli occhi di due perdenti), piuttosto insolita al cinema nostrano. Insomma non una commedia all'italiana, di cui non ha né il tono, né i tempi; ma una commedia italiana. Non ci sembra davvero poco. (M.M)
Il Fantasma (O Fantasma) di Joâo Pedro Rodrigues (Concorso)
O Fantasma, ovvero le avventure erotiche di un netturbino gay portoghese, Sergio (Ricardo Meneses) che, con la sua tutina fetish in lattice nero, si aggira guardingo nella notte, come un supereroe della Troma. Razzolando fra i rifiuti, percorre le tappe di una discesa agli inferi (o meglio nel cassonetto), divorato da una passione amorosa non ricambiata e in fondo pretestuosa: la pulsione erotica spinge infatti il Nostro a copulare con qualsiasi cosa, animata e non, gli capiti a tiro: moto, poliziotti, pareti della doccia, avventori di bagni pubblici, colleghi e colleghe, mutandine usate. L'amico, a lungo andare, esce di testa: indossa la tutina di latex sadomaso, sequestra l'oggetto della sua passione e lo malmena ben bene, per poi fuggire in quello che in fondo è lo sbocco naturale della sua esistenza monnezzara: la discarica comunale. Qui, un po' Diabolik e un po' Fantomas, la sua silohuette fruga fra i rifiuti, si abbevera alle acque di scolo e caccia leprotti, probabilmente per cibarsene (ma, visti i precedenti, non è detto). Film apertamente sgradevole, che gioca la carta del disagio dello spettatore e lo spiazza con un finale enigmatico, in cui però non riesce ad evitare un surplus di comicità involontaria, che strappa allo scafato pubblico veneziano ghignate a scena aperta. Ma il riso tradisce qualche imbarazzo, che pure il film riesce a creare, con momenti di esplicita durezza: mostrando ad esempio un lungo primo piano di fellatio nei bagni pubblici, o evidenziando la simbiosi quasi fisica ed alimentare che lega l'ameno protagonista ai rifiuti in cui sguazza per tutto il film. Forse non basta a farne un capolavoro, ma di sicuro un oggetto non ben inquadrabile: non completamente riuscito, ma degno di interesse.(T.B.)
Pollock
di Ed Harris (Cinema del presente)Pollock segna il debutto alla regia di Ed Harris, uno degli attori più incisivi e meno acclamati del cinema americano. Una scelta, quella di raccontare la vita del maestro dell'Espressionismo Astratto, audace e fuori dagli schemi, che conferma la capacità di Harris di alternare a grandi produzioni hollywoodiane (Apollo 13, The Truman Show, solo per citarne un paio) film meno allineati agli standard dell'industria. Poteva essere solo uno dei tanti corretti ed insipidi biopic artistici (da Wilde a Lautrec), che hanno attraversato i nostri schermi negli ultimi anni, ma Harris riesce a rendere autentica e plausibile una figura pure complessa e sfuggente come quella di Jackson Pollock. Il regista si concentra soprattutto sul rapporto conflittuale con la moglie Lee Krasner (anche lei artista astratta, anche se di fama minore) e sul clima di produttiva rivalità instauratosi con colleghi come De Kooning e Gorky. Harris insiste molto sulla tecnica innovativa che Pollock elaborò (il cosiddetto dripping, letteralmente gocciolamento), che gli aprì le porte della celebre galleria di Peggy Guggenheim "Art of this century", consentì alla pittura americana di sganciarsi dal provincialismo e dal regionalismo della scena statunitense e a New York di divenire la Mecca mondiale dell'arte contemporanea. Ma quello che colpisce è il rigore e la sobrietà con cui Harris trasformi Pollock in una sorta di eroe classico della cultura americana del dopoguerra, un po' Brando e un po' James Dean, una personalità autentica ed autodistruttiva, la cui fine prematura (morì ubriaco e solo in un incidente stradale nell'estate del 1956) sembra un'inevitabile, ma logica conseguenza. (M.M.)
My Generation
di Barbara Kopple (Cinema del presente)La storia di Woodstock. Ovvero Pace, Amore e Merchandising. La pluripremiata Kopple (due Oscar per miglior documentario nel '77 e nel '91), già presente due anni fa a Venezia con Wild Man Blues, un ritratto ravvicinato di Woody Allen e della sua New Orleans Jazz Band, realizza una sorta di "rockumentary" con l'intenzione di mettere a fuoco analogie e differenze tra le tre edizioni (1969, '94, '99) del più celebre e raccontato evento musicale americano. Scopriamo così che il nome Woodstock non dovrebbe evocare, nella memoria collettiva, solo battaglie per la liberazione sessuale e sociale, figli dei fiori e marjuana, ma anche sponsorizzazioni, avidità e speculazioni. Quando nel '69 Michael Lang, organizzatore e mente della manifestazione nonché guru della controcultura hippie dell'epoca, creò il primo festival musicale al mondo (ma allora nessuno ancora lo sapeva), non aveva certo intenzioni filantropiche. Calcolato male il budget, si trovò a dover scegliere tra ultimare la costruzione del palco oppure erigere il "simbolico" recinto, necessario per riscuotere il prezzo del biglietto. Ovviamente scelse il palco. Così, suo malgrado, nacque il fenomeno Woodstock. E' chiaro che evidenziare in modo così insistente l'aspetto economico insito non solo nelle due edizioni degli anni novanta (con le band che parlano di recuperare lo spirito del concerto originale, mentre contemporaneamente i loro cachet giganteggiano in enormi didascalie), ma anche nel Woodstock originale (glorificato dal documentario musicale di Wadleigh), ha oggi il potere di una dissacrante operazione revisionista. Perseguitati dal mito di Woodstock, ai ventenni di oggi non resta altro che fare "moshing", rotolarsi nel fango per scaricare l'energia negativa. Eppure nonostante il ghigno impassibile di Lang e le sue sponsorizzazioni, quando sullo schermo appare Janis Joplin, che intona "Just a little bit harder" un brivido di commozione attraversa la sala. È proprio vero: il mito di Woodstock è invincibile. (M.M.)